Il totano evoca l'abisso e l'oscurità e, viste le quote operative, produce nel pescatore una gran quantità di adrenalina durante tutto il lungo percorso di risalita e finché il diavolo rosso non viene finalmente issato a bordo.
Il totano gigante, chiamato anche “diavolo rosso”, è una creatura molto affascinante, quasi aliena, che vive nelle oscure profondità abissali. Si tratta di un cefalopode presente specialmente nella fascia costiera tirrenica dell’Italia meridionale, in particolare al largo delle coste campane, calabresi e siciliane, sulle batimetriche comprese tra 350 e 800 metri. Si tratta di mollusco famelico e aggressivo, con due enormi occhi che lo abilitano alla caccia in quella che per noi è oscurità totale. Le caratteristiche braccia sono dotate di enormi ventose con anelli cartilaginei dentellati per una maggiore presa. La taglia media del totano gigante (Ommastrephes caroli), si aggira intorno ai 4-5 kg, ma è comune la cattura di esemplari di peso superiori ai 10. Il periodo migliore per insidiare questa preda va da marzo a settembre. Per impostare una corretta battuta di pesca occorre individuare lo spot. Di norma si esamina la cartografia disponibile preferendo le batimetriche dai 400 agli 800 metri con rapide variazioni di profondità. Dopodiché ci si reca sul punto e si accende il motore elettrico di prua per assicurarsi una posizione stabile, resistente al vento e alla corrente. In mancanza dell’indispensabile ausilio ci si arrangia col paracadute o, in ultima analisi, al motore principale, da utilizzare in retromarcia. In ogni caso, per mantenere a livelli accettabili la verticalità della lenza, lo scarroccio deve stabilizzarsi a una velocità inferiore ai 0,3 nodi.

Canna e mulinello - Considerata la mole importante e la notevole resistenza che può opporre un grosso totano, la canna deve essere una 20-30 lb con azione parabolica, alla quale abbinare un mulinello elettrico con un drag di almeno 20 kg, capace di contenere 1000 metri di ottimo multifibre 8 capi di almeno 70 libbre, all’estremità del quale possiamo fissare, dopo aver inserito un facoltativo spezzone di 5 metri di nylon 0,90, un moschettone, la girella con moschettone da almeno 300 libbre. Il nylon “facoltativo” potrebbe avere dei riscontri positivi se volessimo dotare di un minimo di elasticità il complesso pescante. Viceversa è sconsigliato nelle giornate con mare mosso, quando è importante avere un perfetto controllo dell’esca e quindi una maggiore rigidità della terminalistica. Tanto dovrebbe assicurare un recupero sicuro anche con una preda di mole inattesa.

Totanara - In quanto a dimensioni sono da preferire quelle grandi con almeno tre anelli e cestelli di ampie dimensioni, almeno 70 mm di diametro. In commercio esistono numerose totanare già pronte e montate con aste in vari materiali (teflon o metallo) e con cestelli di dimensioni e pesi differenti. Io preferisco il do it yourself, partendo da una barra filettata di acciaio inox da 8 mm lunga un metro, che taglio della lunghezza giusta in base alle esigenze di pesca. Poi effettuo le saldature necessarie all’interno dei cestelli per fissare i dadi inox, in modo da poterli avvitare sulla barra filettata alle altezze desiderate. Nell’estremità inferiore della totanara fisso il piombo a forma conica con filettatura interna del peso variabile da 500 a 1000 g. Nell’estremità superiore aggiungo l’anello per agganciare la girella con moschettone. Con tale configurazione, in base alla corrente e alla profondità di pesca, è possibile cambiare la zavorra e variare il peso totale della totanara tra i 750 a 1500 g. Un aspetto di estrema importanza è l’esca di richiamo. Le migliori, oltre alle consuete sarde, sono i sauri e il pesce spatola sotto sale. In mancanza di questi, è possibile utilizzare anche lardo o carne di maiale.


La corretta posizione della canna è orizzontale rispetto alla superficie dell'acqua. Manuel e il cefalopode in tutta la sua lunghezza.
In pesca - Una volta calata la totanara sul fondo, si deve sollevare l’impianto pescante di circa 10 metri e attendere circa 5 minuti eventuali strike. Se il tentativo non rende si recupera 30 metri e si aspetta qualche minuto per poi ripetere lo stop & go finché arriva la mangiata. Considerate che gli esemplari più piccoli generalmente stanno sul fondo mentre i più grossi, di peso anche sopra i 10-15 kg, spesso sono sollevati anche 200-300 metri. Nel caso di esemplari di mole, le abboccate sono facilmente avvertibili sulla canna in quanto a un appesantimento evidente, si susseguono pompate molto energiche, tipiche del diavolo rosso rimasto preda del nostro inganno. In questa fase è importante ferrare subito il cefalopode inserendo la marcia di recupero del mulinello e impostando la frizione sul giusto valore per un recupero costante, senza interruzioni, per evitare la perdita della preda. A questo punto non ci resterà che goderci il nostro lungo recupero dagli estremi abissi fatto di ripetute flessioni della canna con il mulinello che spesso andrà sotto sforzo e, dopo qualche blocco e slittamento della bobina, riprenderà a velocità di recupero fino alla successiva pompata.

PRESENTAZIONE SPECIE
a cura di: Prof. Danila Cuccu - Dip. Scienze della vita e dell’ambiente UniCa
Ommastrephes caroli (Furtado, 1887)
REGNO: Animalia
PHYLUM: Mollusca
CLASSE: Cephalopoda
ORDINE: Oegopsida
FAMIGLIA: Ommastrephidae
SOTTOFAMIGLIA: Ommastrephinae
GENERE: Ommastrephes
SPECIE: Ommastrephes caroli
Caratteristiche diagnostiche - Presenza di fotofori a livello cutaneo e sub cutaneo del mantello ventrale, della testa e delle braccia ventrali. Totale assenza di fotofori in zona dorsale del mantello. Nella zona ventrale del mantello è presente una banda dorata o argentata che, a partire dall’apertura del mantello, si diparte in tutto il corpo lungo la sua linea mediana fino a raggiungere l’apertura delle pinne. Nei tentacoli il dactylus, presenta 4 serie di piccole ventose. Il carpo presenta da 4 a 7 ventose munite di dentelli, organizzati in modo da essere uno per ogni quadrante individuabile all’interno della circonferenza della ventosa. Questa caratteristica risulta fondamentale per il riconoscimento del genere. Le braccia presentano un numero di ventose che va da 24 a 35. Nel III braccio ventrale sono presenti delle membrane protettive molto larghe, che negli individui di sesso femminile si espandono per andare a formare dei voluminosi lobi triangolari. Nei maschi, il braccio ventrale sinistro o destro è privo di ventose in seguito alla trasformazione in ectocotile. Le pinne rappresentano, in lunghezza, dal 40 al 50% della lunghezza totale del mantello e in larghezza corrispondono al 60-85%. Questa specie è caratterizzata da individui di dimensioni che vanno, per le femmine, da 80 cm a 90 cm di lunghezza per un peso che si inserisce nell’intervallo di 20-25 kg, mentre i maschi raggiungono dimensioni più modeste, rimanendo all’ interno dei 42 cm di lunghezza per 2 kg di peso (Roper et al., 2010).
Distribuzione geografica e catture - Attualmente la distribuzione di O.caroli è ristretta al Nord est Atlantico e Mediterraneo (Fernández-Álvarez et al., 2020). Nel complesso, i ritrovamenti in Mediterraneo sono considerati un fenomeno fortuito, che si verifica principalmente nel bacino orientale, generalmente dovuto a grandi femmine senescenti post-riproduzioni, spiaggiate o catturate accidentalmente durante la pesca commerciale o sperimentale a circa 500-600 metri di profondità. (Lefkaditou et al., 2011; Kapiris et al., 2014; Franjevi´c et al., 2015; Tsiamis et al., 2015) Il basso numero di esemplari registrati nel Mediterraneo potrebbe essere dovuto all'assenza di una pesca mirata. Solo al largo delle Isole Eolie è una specie oggetto di cattura accessoria (<3%) della pesca a jigging (Battaglia et al., 2010; Lefkaditou et al., 2011). Tuttavia, la scarsità di segnalazioni contrasta con la sua frequenza di presenza nel contenuto gastrico dei grandi predatori come il pesce spada (Bello,1991; Romeo et al., 2012), suggerendo che la specie potrebbe non essere così rara.
Biologia - O. caroli come tutti i cefalopodi coleoidei effettua un solo evento riproduttivo a cui fa seguito la morte (semelparità). Le conoscenze biologiche della specie in Mediterraneo sono frammentarie. Solo recentemente uno studio (Agus et al., 2021) effettuato su alcuni esemplari delle acque sarde ha fornito alcune informazioni sulla riproduzione, dieta ed età della specie. Le femmine mature producono sino a 840000 uova (0,05-1,10 mm) e dopo accoppiamento di tipo “testa-testa” ricevono nei ricettacoli seminali posti nella membrana buccale i prodotti sessuali maschili (spermatofore) che andranno successivamente a fecondare le uova pronte per essere deposte. Pur riproducendosi una sola volta sono capaci di più deposizioni durante le quali continuano a nutrirsi. Le uova fecondate vengono raccolte e rilasciate in strutture nastriformi sospese nella colonna d’acqua. La stima dell’età effettuata attraverso l’analisi delle mandibole (o becchi) di individui di entrambi i sessi ormai nella fase finale della vita suggerisce per la specie un ciclo vitale di circa 12-13 mesi.
Dieta e predatori - Dall’analisi dei contenuti stomacali emerge una dieta a carico di altri cefalopodi ma anche di crostacei e pesci ossei.

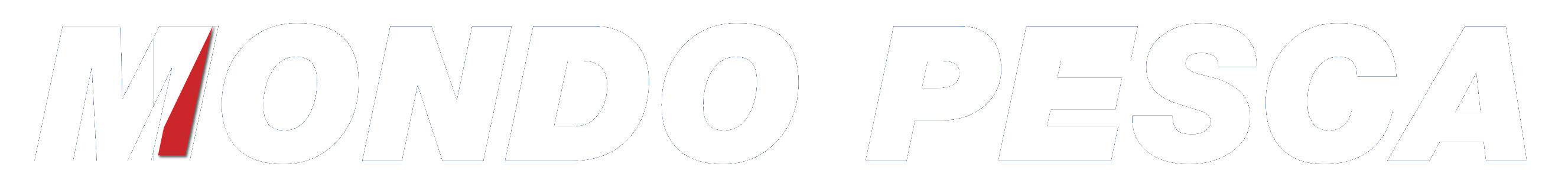

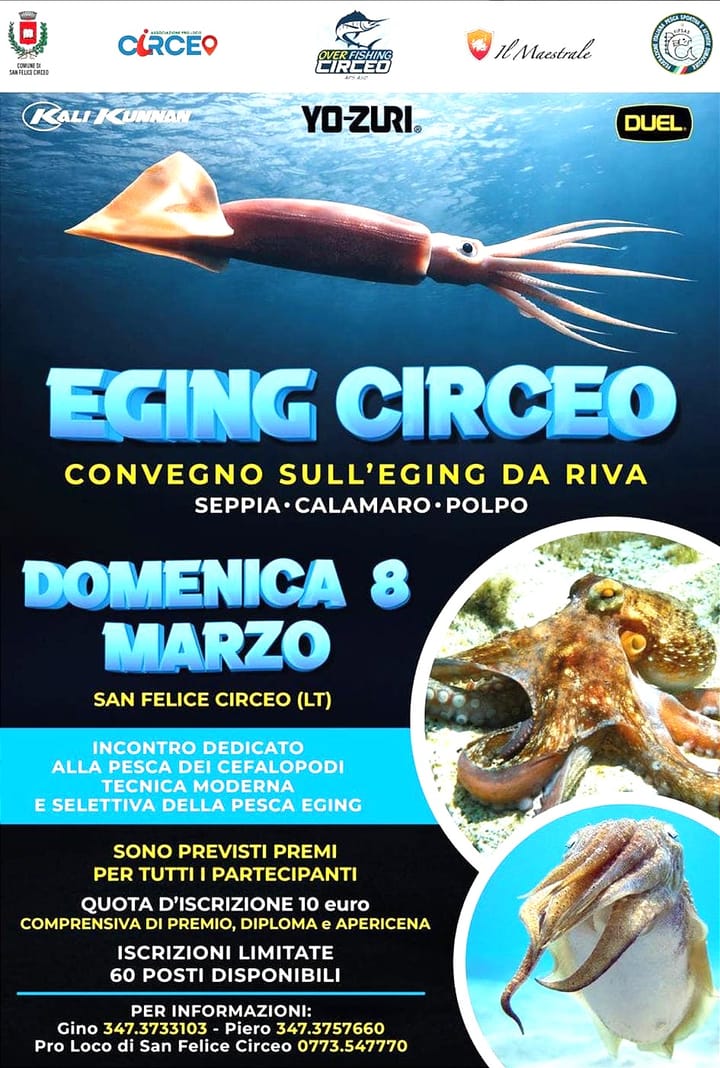


Commenti ()