Con questo articolo l'autore interpreta i latini del "miscere utile dulcis". Infatti, se la passione - in questo caso la pesca - è utile alla scienza - in questo caso la genetica - il successo è assicurato, in campo sportivo, come nella ricerca.
Che relazione ci può essere tra un sardo e le Alpi? E che cosa unisce una tecnica di pesca antica, forse elegibile ad arte, quale la pesca a mosca secca, con una tecnica di laboratorio relativamente moderna, come l’analisi del Dna? Presto detto: chi scrive per questa rivista per la prima volta è uno studioso di pesci proveniente dalla Sardegna, super appassionato di pesca nelle acque dolci e approdato di recente nel mondo magico del fly fishing. E ha voluto approfittare della conoscenza di un altro ragazzo sardo, Cristian Sechi, lui ormai trapiantato (definirlo alloctono naturalizzato in questo contesto non guasterebbe) in quelle fantastiche terre ricche di acque e di pesci, caro amico di me che scrivo, oltre che grande moschista e appassionato di scienza. Lui è il mio mentore, io il suo allievo.
Poiché da anni mi occupo dello studio della fauna ittica, con particolare riguardo allo studio delle scientificamente “malefiche” trote fario, ho pensato di proporre a Cristian, già a partire dallo scorso anno un percorso fatto di pesca - tassativamente a mosca secca - e di scienza, con lo scopo di poter recuperare piccoli campioni di trota fario e analizzarle geneticamente all’Università di Sassari, per provare a fare un po’ di chiarezza sulla loro genetica, che ormai da tempo solleva tanti interrogativi e ostacola eventuali progetti di ripopolamento.
Pesci e tecnica - Ma ora parliamo di pesci e tecnica. Dei pesci è presto detto, in quelle acque l’obiettivo principe sono le trote fario, ma spesso si incappa in altri salmonidi, tutti interessanti a loro modo, o per importanza conservazionistica e rarità crescente, quali i superbi temoli, oppure per livree fantastiche e combattimenti al fulmicotone, come le trote iridee.

Il programma di pesca lo fa come sempre Cristian, grande conoscitore di queste acque cristalline e rapide, che ha i compiti più importanti per la spedizione nel weekend: selezionare i siti dove trovare campioni e… fare pescare il sottoscritto che fa tanti chilometri, attraverso mari e terre. Questa volta tocca alle Alpi piemontesi.
Primo giorno - I torrenti della Val Formazza sono il nostro target. Sveglia puntata alle tre del mattino per essere presto in pesca, ci aspettano un paio di ore di camminata tra valli di granito candido coperte da maestosi e verdi larici. Arriviamo sullo spot con la nostra attrezzatura di ordinanza per un fly fisher sui torrenti della Penisola: canna 7.6 piedi super reattiva Italian style, coda #3, terminale conico 9 piedi 5X (0.15), tippet in nylon 0.13 di circa 1 metro. Le acque al mattino non sono ancora scaldate dal sole e gli insetti non volano, quindi si opta per una sedge da caccia montata su un amo barbless del 16, che si rivela subito la scelta ottimale. Si inizia a portare pesci al guadino, principalmente trote iridee nella spettacolare livrea “leopard” (varietà di Oncorhynchus mykiss) e qualche “gola rossa” (Onchorinchus clarkii), entrambe specie non native ma ormai naturalizzate. Infine, ad aumentare la biodiversità specifica di tanto in tanto si interessa alle nostre mosche secche qualche colorato e vorace salmerino (Salvelinus fontinalis), piccolo principe delle spianate con acque correnti.

La giornata scalda, e qualche effimera inizia a fare la sua magica danza sulle acque. Alla immissione del torrente in un laghetto artificiale Cristian mi suggerisce ti montare una imitazione montata su amo 18 (le mosche sono tutte magistralmente autocostruite da Cristian, N.d.A.) e dopo un paio di lanci ferro uno dei Salmonidi che popolava i miei sogni da ragazzo: un temolo (Thymallus thymallus) sulla quarantina, che tardo a liberare per poterlo ammirare, penso si chiami sindrome di Stendhal…


Marco Casu con un meraviglioso temolo e Cristian Sechi con una bella fario.
Ma ora arriva il momento dell’obiettivo “scientifico”, le trote fario (Salmo “vattelapesca” poiché la tassonomia di questa specie è ancora tutta da scoprire), che nel pomeriggio piovigginoso non tardano ad attaccare nuovamente sedge e imitazioni di ant (formiche), sempre su amo del 16. Con tanta delicatezza vengono raccolti i campioni di pinna per la genetica e poi le trote si rilasciano immediatamente. Dimenticavo, una marmorata (Salmo marmoratus) di dimensioni interessanti allieta la giornata di Cristian, che nel frattempo ha portato a guadino pesci nel rapporto di 5 a 1 rispetto al sottoscritto!
Secondo giorno - Sempre con ritmi militari, si va in Valle Antrona. Ci attende una sorpresa non molto gradita a chi pesca a mosca secca: acqua da neve, fredda, che spesso blocca i pesci sul fondo. Sono disperato… ma dimentico colpevolmente che la mia guida, spirituale e fisica, nella pesca a mosca, sa leggere acque e pesci, e trova una soluzione: montiamo prontamente la nostra amata formica, amo 16, con foam bianco, e lui inizia a catturare temoli argentati. Io purtroppo sono ancora novizio, li faccio salire sulla mosca, ma poi perdo la ferrata, ma sono sempre felice di vedere che il mio amico trova soluzioni e si diverte a pescare. Anche qualche intirizzita trotella fario finalmente abbocca, e viene campionata e liberata velocemente. I luoghi fantastici mi riempiono il cuore, ma il pescatore che vive in me vuole vedere la canna piegata e la coda in tira… Cristian mi indica una piccola pozza ai miei piedi, un lancio preciso, e un bel temolo goloso non si fa pregare a bollare e mi fa felice per i prossimi mesi.


L'autore con una trota gola rossa e Cristian con una bellissima trota marmorata.
Terzo e ultimo giorno - Si arriva sul Toce. Quando si pesca è sempre bello, ma la giornata sarà tra le più difficili. Iniziamo in un tratto con acqua veloce, e qualche trota fario viene ingannata nuovamente dalle nostre sedge, ma dopo un’oretta l’impeto del Toce aumenta, complice l’apertura della meravigliosa cascata più a monte, e siamo costretti a dirottare la nostra voglia di catture su un tratto qualche chilometro più a valle. Qui all’ira delle Potamidi, ninfe dei fiumi, si sostituisce il fantasioso Eolo, dio dei venti. Pesca a mosca con attrezzature leggere e raffiche non vanno d’accordo, e pur tuttavia insistiamo e - confesso - complice anche qualche innocente imprecazione, qualche coraggiosa trota fario bolla sulle nostre mosche. Il mio bottino (ma solo il mio) è magro, ma la soddisfazione di riuscire a pescare a mosca secca in quelle condizioni è tanta.
Alla sera ci abbracciamo con Cristian, e mi dirigo verso la mia Isola, con tanta soddisfazione per i pesci catturati (e campionati) e per l’applicazione della tecnica: tutti i consigli di Cristian e i corsi di perfezionamento SIMfly frequentati hanno fatto salire l’asticella. “Torna a settembre” mi dice Cristian. Io penso sia una citazione alla famosa commedia, e invece è una proposta di pesca, che ho già accolto. Biglietti fatti!

Come ittiologo all’Università di Sassari mi interesso di diversi problemi conservazionistici che riguardano le specie ittiche della Penisola e non solo. Tra queste la trota fario in Italia e una specie “sfidante” poiché la sua posizione tassonomica è ancora tutta da chiarire, e questo fatto pone anche numerosi problemi gestionali, soprattutto in caso di immissioni. Cosa deve essere seminato? Questa situazione mi ha portato a intraprendere, assieme a Cristian Sechi, uno studio sulle trote fario presenti in alcune acque del nord Italia.
Trota mediterranea? Trota marmorata? Ibridi con i ceppi atlantico o danubiano? Per rispondere a questo interrogativo, oltre che le attrezzature tecniche, portiamo a pesca con noi delle provette, dell’alcol non denaturato al 95% e una forbicina. Ad ogni campione di fario, prima del rilascio, viene asportato un piccolo pezzo di pinna caudale (“finclip”) e viene fotografato per la livrea e la dimensione. Il pezzettino di caudale viene conservato in alcol e numerato, cosi come la fotografia corrispondente. I campioni vengono poi analizzati geneticamente nei nostri lab dell’Università di Sassari per capire l’aplotipo mitocondriale di appartenenza (mediterraneo, marmorato, atlantico, etc.) e se sia ibrido o puro. Niente spoiler, work in progress! Voglio solo sottolineare come pesca e scienza possano essere un binomio vincente per la conservazione delle specie delle nostre acque, non solo interne.

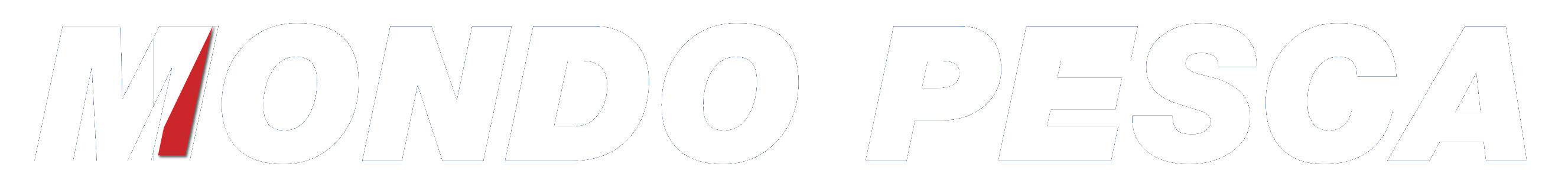

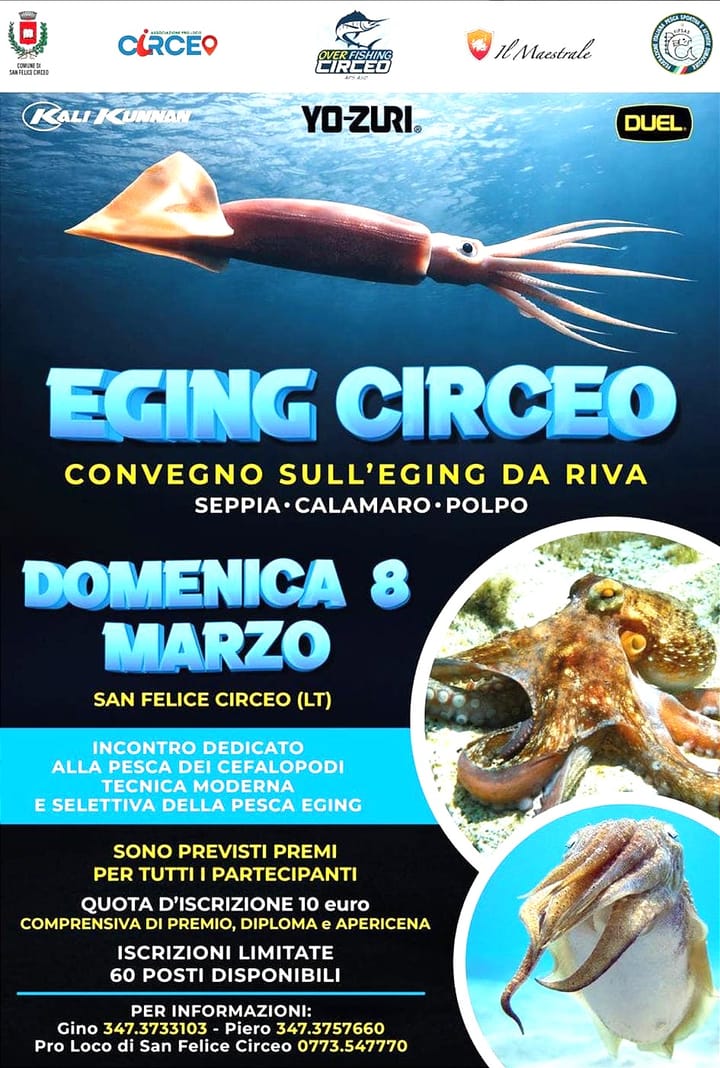


Commenti ()